C’è una Milano che ci piace perché non dimentica il suo passato e non dimentica di essere stata una città dove si respirava un’aria di libertà e di dinamismo, molto accogliente verso le minoranze.
Le urla di una certa politica, che sa dire solo no e teme tutto ciò che è altro da sé, questa volta sono state zittite dal calore di mille candele e di tanti striscioni che dicevano “Qui a Milano nessuno è straniero” o “Niente desaparecidos, fermiamo la strage dei confini”.
La via milanese nella gestione dei migranti
Secondo i dati rilasciati dal Prefetto Alessandro Marangoni all’inizio del mese, Milano città, da sola, sta sostenendo da mesi il 70 per cento dell’accoglienza destinata a tutta l’area metropolitana, composta da 133 sindaci che dovrebbero suddividersi 4500 profughi.
E’ evidente però che non tutti fanno la loro parte. Alcuni sindaci hanno ribadito al prefetto il loro no secco all’accoglienza, anche di fronte all’evidenza di un meccanismo di redistribuzione nazionale dei migranti, piano secondo il quale alla Lombardia va il 14 per cento di tutti i migranti che vengono identificati allo sbarco nei porti del Sud Italia.
Il piacere verso i gesti di solidarietà di questa Milano che accoglie più dei suoi vicini, mi nasce da una motivazione profonda legata all’esperienza diretta che ho fatto delle ragioni che spingono centinaia di uomini, donne, bambini a lasciare tutto e a rischiare la loro vita in “viaggi della speranza”, che invece spesso sono senza alcuna speranza.
 I miei tre anni in Africa
I miei tre anni in Africa
C’è stato un tempo in cui da collaboratrice Ansa, per tre anni, dal 2008 al 2011, ho fatto la corrispondente dalla Libia, vale a dire che ero dall’altra parte della sponda del Mediterraneo ed è lì che ho avuto l’opportunità di vedere e di capire cosa succede a chi lascia la sua terra e perché si scappa.
Ho toccato con mano e letto negli occhi di tanti uomini e donne storie di fame, di povertà, di persecuzioni, di guerre, di usanze tribali violente e pericolose.
Mi sono finta suora per entrare nelle carceri dove Gheddafi rinchiudeva i clandestini. Sono entrata nei nascondigli degli eritrei che, in attesa di trovare i soldi per un passaggio verso l’Europa, si nascondevano dalle persecuzioni dei libici e dei trafficanti di esseri umani. Ho percorso chilometri di spiagge alla ricerca dei punti di raccolta dei migranti. Ho fotografato i barconi di legno e poi i gommoni con cui i trafficanti di uomini trasportavano i migranti.
Ho imparato le rotte e le tappe di un cammino che dal cuore dell’Africa, attraverso percorsi diversi, su camion, a piedi, portava uomini e donne verso le coste. Prima a terra, nel lungo viaggio attraverso l’Africa e i suoi deserti, passando, a seconda della provenienza per Gao, Agadez, Kufra, Ghat, Seba fino ad arrivare ad Adjabia, Gadames, per poi nascondersi e mendicare in attesa di trovare i soldi per partire da qualche spiaggia come Garabuli o Sabratha.
Ho visto cadaveri, rinsecchiti, raccolti nel deserto, o gonfi e spellati, rigettati dalle acque del mare. Ho fotografato le loro tombe nei cimiteri di Tripoli dove al posto del nome c’era la data e il luogo del ritrovamento.
Ho parlato con le nigeriane, maltrattate e stuprate ancor prima di arrivare a Tripoli, nelle mani di organizzazioni che con l’inganno le strappavano alle loro famiglie e poi con il ricatto delle credenze tribali le tenevano in pugno per il resto della loro vita.
 Ho chiesto loro: perchè rischiate la morte per fuggire dal vostro Paese?
Ho chiesto loro: perchè rischiate la morte per fuggire dal vostro Paese?
Ho chiesto a tutti quelli che ho incontrato perché lasciavano la propria terra, la propria famiglia, le proprie origini per rischiare la vita e arrivare nella fortezza Europa dove nessuno o in pochi sono felici di accoglierli? Perché rischiare ancora la morte fra le onde dopo essere riusciti a sopravvivere al viaggio attraverso il deserto?
La risposta è stata sempre la stessa, sia che venisse da un giovane proveniente dall’Eritrea di Isaias Afewerki o dal Gambia di Jammeh o dal Burundi di Kurunziza, tutti presidenti padroni e tiranni, sia che venisse da una ragazza nigeriana o da una donna Somala. “Cerchiamo una vita migliore”.
Allora mi chiedo: che diritto abbiamo di giudicare chi come noi cerca una vita migliore? Non è forse quello che anche noi facciamo ogni giorno? Non è forse quello che i nostri nonni hanno fatto dopo la guerra? Non è forse quello che i nostri giovani cervelli fanno fuggendo verso l’Europa o gli Stati Uniti? Non è quello che ho fatto io lasciando Roma per venire a Milano?

FRANCESCA SPINOLA
Leggi anche:
* 10 città stato del mondo che possono ispirare Milano
* E ora Milano Città Stato! Se non lo fa l’Italia, si può chiederlo all’Europa
* Milano Città Stato sarebbe un bene soprattutto per l’Italia
* Primo passo del consiglio comunale verso Milano Città Stato
* Corrado Passera: Milano Città Stato è il più interessante progetto che ci sarà in Europa nei prossimi anni
* “Proviamoci. Mi impegnerò personalmente”. Beppe Sala a Milano Città Stato
VUOI CONTRIBUIRE ANCHE TU A TRASFORMARE IN REALTA’ IL SOGNO DI MILANO CITTA’ STATO?
SERVE SCRIVERE PER IL SITO, ORGANIZZARE EVENTI, COINVOLGERE PERSONE, CONDIVIDERE GLI ARTICOLI, PROMUOVERE L’ISTANZA, AIUTARE O CONTRIBUIRE NEL FUNDING, TROVARE NUOVE FORME UTILI ALL’INIZIATIVA.
SE VUOI RENDERTI UTILE, SCRIVI A INFO@MILANOCITTASTATO.IT (OGGETTO: CI SONO ANCH’IO)





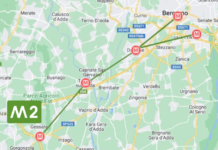









Che poi io penso che da occidentali con tanta storia alle spalle dovremmo chiederci se la “vita migliore” che sembriamo offrire e rappresentare al mondo sia poi quella da desiderare verso cui ambire. E lo dico non per un populista lasciamoli dove sono: so benissimo che la comparazione tra le due realtà è impossibile. Ma perché ritengo che noi per primi dovremmo ripensare a cosa significhi una vita migliore: non certo quella delle nostre città convulse e non accoglienti, dove c’è sempre meno spazio per la condivisione e, quindi, per l’accoglienza. Il problema degli emigranti è il problema del futuro e fonda non più solo sulla colonizzazione (ormai assai remota) ma soprattutto dalla disastrosa e infame cooperazione che abbiamo operato da europei in Africa. L’accentramento nelle grandi città delle popolazioni è un disastro in ogni parte del mondo: nelle magalopoli occidentali, nelle città del resto del mondo e nelle loro bidonville. Dovremmo ripensare ai nostri stili di vita – e lo dico da cittadina convinta – e esportare (come abbiamo fatto nei secoli) la grazia della civiltà, del saper costruire meravigliose città e paesi, del saperci godere la vita ed il tempo libero e non fuggendo a gambe levate il weekend dai posti dove viviamo. La vita migliore esiste ma non è quella che offriamo agli emigranti: sia noi che loro avremmo diritto ad una vita migliore in serenità, accoglienza e condivisione. Le smart city non saranno quelle solo informatizzate e nelle quali non muovere neanche un dito (che poi che traguardo è?) ma quelle in cui ci saranno spazi per l’otium e la condivisione del verde, della cultura, dell’arte e sì anche dell’accoglienza: allora saremo una metà giusta per tutti quelli che vogliono sfuggire dalle loro tristi e violente realtà e forse potremo essere veramente di esempio per insegnare loro come rendere i loro luoghi degni di una vita migliore. . Boh stamani m’è presa così, ma ci credo veramente .. Quando dico che gli articoli dei giornalisti seri stimolano il pensiero ….
La sezione commenti è chiusa.